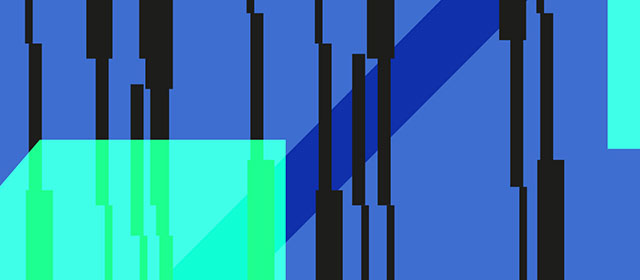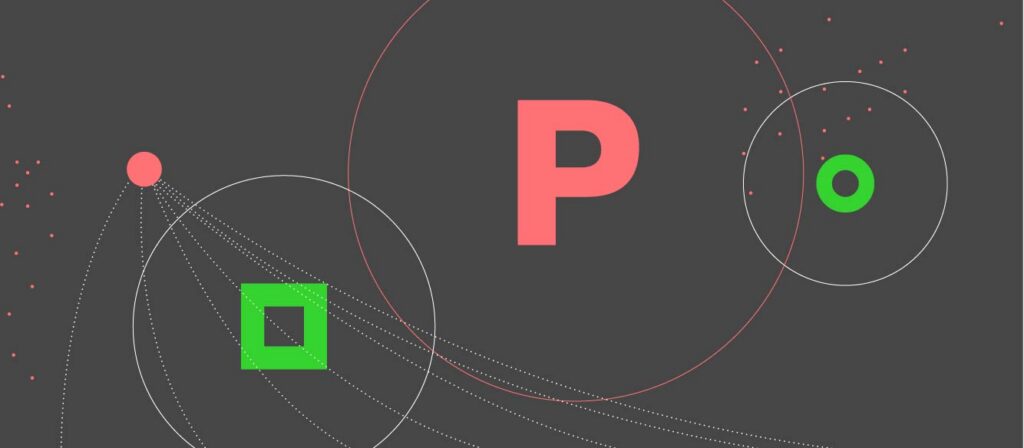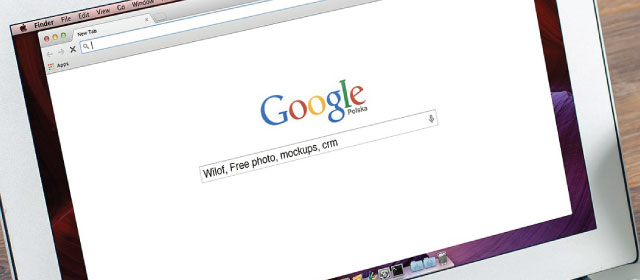Si parla di cambiamento da anni. Personalmente ci lavoro da 25 anni. Logotel dal suo primo giorno. La parola “cambiamento” era sulla prima slide che Giuliano Favini – fondatore di Logotel – ha proiettato durante un evento, in cui gli ospiti – prima di entrare in sala – dovevano saltare una corda tesa all’ingresso. Era un invito a mettere in crisi la propria routine. Il cambiamento (o change) è un capitolo dell’enciclopedia del management, un motore di crisi simil perenne, una reazione culturale a un asteroide che ci aspettiamo stia per arrivare. Un concetto che si è svuotato di significato a furia di ripeterlo come una litania di cui rimane il suono ma si perde la portata. Ecco. Ci siamo. Adesso che abbiamo davvero bisogno di cambiare siamo troppo stanchi per farlo o disattenti o non sappiamo in che direzione guardare perché gli asteroidi sono mille. Come nella favola di Pierino e il Lupo, a furia di gridare “al lupo al lupo” poi nessuno ci crede. E il lupo arriva. E allora sì che si cambia. Ma non per scelta, per imposizione e la cosa potrebbe non essere indolore.
Le organizzazioni economiche sono un costrutto di un paio di secoli fa. Leadership e management sono forgiati per un mondo che si evolve in modo lineare, in un fluire di decisioni che si prendono leggendo nelle stelle dei megatrend. I megatrend li vedevi arrivare e quindi ti preparavi. Ma tutti li vedevano arrivare e quindi tutti si preparavano. Morale: abbiamo per decenni forgiato imprese simili, con competenze simili, processi simili, disegnati da scuole di management simili. Guidati dalla luce del fare benchmark per essere migliori o quantomeno standardizzati, passando per la confrontabilità. Misurati per stare in una classifica o bollinati per dimostrare che, una volta fatte le cose in un certo modo e certificate in un certo modo, allora siamo garanzia di qualità, siamo organizzazioni attendibili e solide.
Oh ma ci pensate? Corriamo per non spostarci, perché abbiamo costruito modelli che diventano strutture dove la dinamica si sacrifica per burocrazia, per efficienza mal applicata, perché non ci sono gli antidoti interni all’avvelenamento da successo o profittabilità. E così la letteratura sul cambiamento si è arricchita di una nuova definizione: change fatigue. È quell’affaticamento che non nasce dal cambiamento in sé, ma dal dover seguire programmi di change management preconfezionati, fuori fuoco, arrivati troppo tardi, quando il mondo si è trasformato (di nuovo).
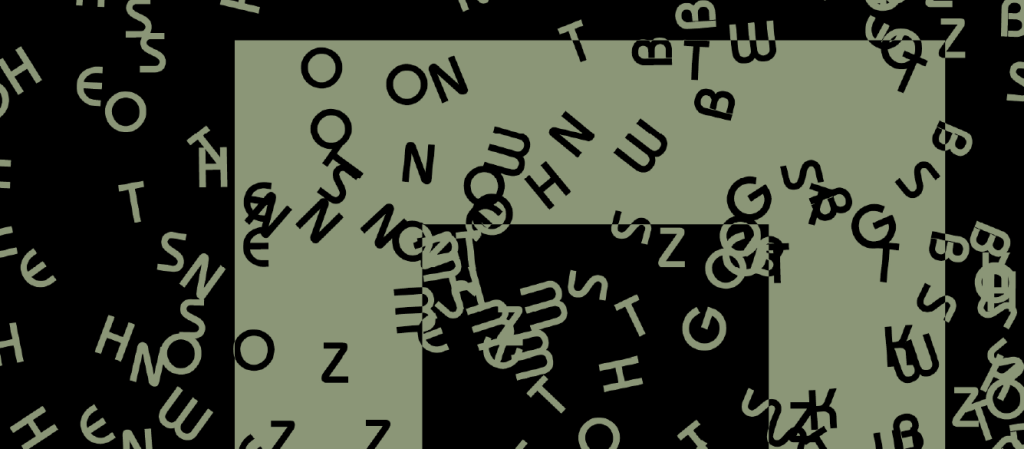
Da dove incominciare a dare un morso all’elefante?
Leader, manager e mestieri. Chi soffre di più sono i manager: schiacciati dal peso di dover cambiare, non sapendo come. Perché lo sguardo dall’alto – quello dei trend, un tempo lineari – si scontra con un contesto confuso, contraddittorio, aporetico. La velocità delle trasformazioni produce un groviglio di paralisi decisionali. Mentre le trasformazioni più potenti stanno avvenendo nella quotidianità: nei mestieri, nelle modalità di lavoro, nelle aspettative di collaboratori e clienti. Se scendiamo nella realtà, ibridando l’onnipotente tecnologia con la capacità di creare, curare e trasmettere contenuti nuovi (il “capitale semantico” di cui parla Luciano Floridi) allora qualcosa di nuovo succede. Ma i manager sono progettati per gestire e spingere (alcuni anche per tirare!). Adesso ci servono manager che liberano spazio, che popolino un nuovo paesaggio organizzativo fatto di ambienti di sperimentazione, occasioni di apprendimento che passano dall’immaginare, provare, spaccare a martellate cose nuove e quindi poco confrontabili: con il passato, con la concorrenza, con i report delle società di consulenza.
Ma se non cambiamo i KPI atavici installati nel kernel del management le cose non funzionano. I KPI di ieri sono in conflitto con la creazione di ambienti e culture che si sanno rinnovare. ROI, chargeability, produttività individuale e le stesse metriche di costruzione del valore sono driver poco utili per navigare il mondo che abitiamo. Perché ci sono metriche che non stiamo ascoltando scandite – con accenti diversi – da istituti di ricerca come Gallup, Ipsos, Pew Research: le persone non si fidano più dei propri leader, l’engagement non è mai stato così basso, i percorsi di learning non sono mai stati così indietro, i programmi di adoption falliscono.
Se ci interessa davvero la produttività, dovremo iniziare a misurare i suoi precursori più potenti: la capacità di innescare motivazione, allenamento di competenze e comportamenti diversi da quelli che ci hanno portato fin qui. La forza di sperimentare, prendere rischi e farsi trainare dal vero talento liberato, raramente conformatosi in un manager felice, deve lottare con il mindset del successo (immediato!). Irrequieti per passione.
Prima di lanciarsi in grandi programmi di change management per stimolare imprenditorialità, parola tornata di gran moda, lavorare sulle condizioni che la rendono possibile: il management e nuove metriche. Vediamo già le facce dubbiose di persone che stanno pensando “queste cose dovreste dirle al mio capo”. Facce rigorosamente a due dimensioni perché il “workshop di engagement” è stato organizzato a distanza perché più efficiente. Boom!
Leader. A voi costruire e soprattutto saper narrare il senso del tutto. Accendere un suono che si propaga forte e chiaro nel rumore del quotidiano.
Orientare aspettative con sincera immaginazione. Per bucare la fatica da cambiamento e il superare il cerume della abitudine servono intensità, ripetizione, nitidezza, potenza, coerenza. Coerenza che – oggi – vuol dire saper abitare le contraddizioni e gli stop and go. E trarne vantaggio. Il mondo incerto e imprevedibile non ci mette al riparo da ripensamenti, cambi di bordo, aggiustamenti alle vele e alla tattica, ma dobbiamo saper costruire una melodia che raggiunge tutto e tutti. Dove i silenzi sono pause per dare ritmo (non è musica senza pause fra le note) e non latitanza di senso e attenzione.
Il cambiamento è un vettore che si genera dalla capacità del singolo di interagire e collaborare con altri. Chiedere, rispondere, discutere, allearsi, trovarsi, aiutarsi.
Per questo bisogna realizzare rapidamente ecosistemi basati su logiche di community (altra parola su cui il senso si è perso a furia di ripeterla come un gadget), dove la varietà e frequenza dei legami che attivano le persone sono le proprietà emergenti del vero cambiamento e non un dato a consuntivo.
E la motivazione? Non è un input ma un outcome. Incominciare a suonare le note tesse la melodia che produce motivazione. Riprodurre quell’eccitazione che ha il bambino quando scopre e impara è buona. Aiutare le persone a capire l’impatto del proprio lavoro sul valore che si vuole costruire insieme è il vero anti-stress. E la motivazione nostra e delle persone che lavorano con noi sarà il moltiplicatore che trasmette il moto nel tempo. Non è un tasto. È un risultato che diventa strumento.

Cosa succede in città?
Per il Vasco c’è tanta confusione, a noi creare trailer di futuro con le persone per incominciare a creare una narrativa positiva, partecipata e desiderabile di quello che possiamo fare insieme.
Di meglio.