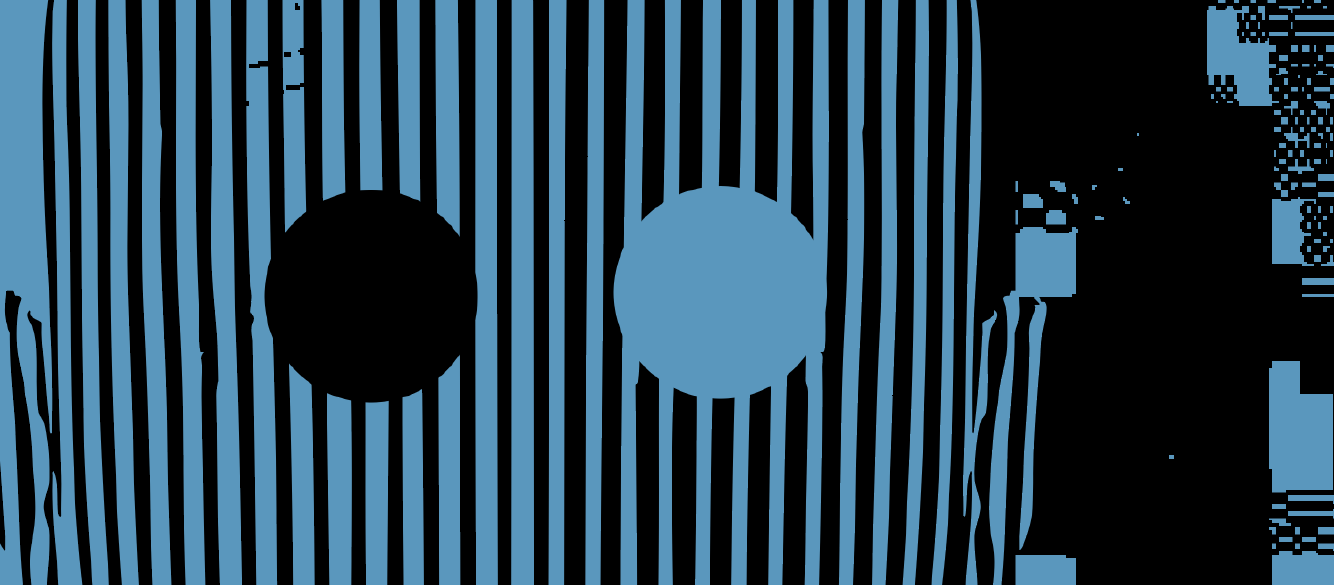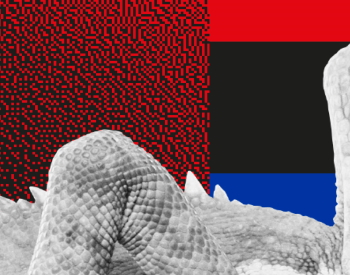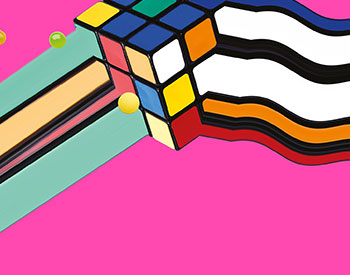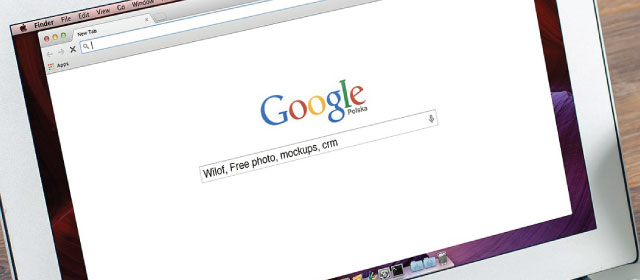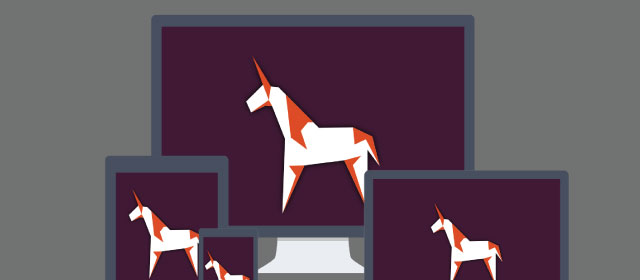Lei sostiene che la mitologia che ha accompagnato l’ascesa di Internet sia ormai defunta, perché colonizzata da piattaforme e algoritmi. In questo scenario post-internet la sfida non riguarda un ritorno all’“ingenuità della Rete”, ma trovare nuove strade…
Innanzitutto, vorrei specificare che l’idea che Internet, considerato anche come un’idea di tecnologia emancipatoria, sia “morto” (idea introdotta, tra gli altri, dall’artista Hito Steyerl qualche anno fa) non significa che sia completamente scomparso. Al contrario l’idea di Internet come tecnologia emancipatoria ha una sua presenza “spettrale”, cioè continua a infestare il capitalismo di piattaforma come una serie di possibilità latenti, ma non realizzate, che resistono anche in maniera conflittuale dentro le piattaforme. L’idea che il vecchio Internet non sia più adeguato e che le piattaforme siano un modello da superare è stata anche sollevata in ambienti più vicini al mondo della programmazione, dove si sta pensando a ripensare i cosiddetti “primi principi” o principi fondanti della comunicazione digitale. Mi sembra però che questi tentativi e ripensamenti manifestino una ideologia libertaria e individualista che è inadeguata rispetto alle sfide politiche di questo momento che è stato definito di “poli-crisi”. Un altro modello è quello del fediverso, ma anche su questo la discussione è aperta. Sicuramente ci sono altre sperimentazioni tecniche in atto, che varrebbe la pena ricercare. La sfida è rendere queste tecnologie davvero popolari e diffuse, in un contesto invece in cui l’infrastruttura tecnica dell’attuale comunicazione digitale è saldamente in mano a grandi aziende. Non ci sono soluzioni semplici: il modello del vecchio Internet è inadeguato a una dimensione di comunicazione digitale di massa e il capitalismo delle piattaforme è essenzialmente un meccanismo estrattivo. Come si esce da questo doppio impasse?
Nel passaggio dal digitale al post-digitale, lei parla dell’importanza di recuperare la dimensione materiale e hardware. Come si manifesta questa tensione tra dematerializzazione delle piattaforme e bisogno di corporeità?
Friedrich Kittler, grande teorico tedesco dei media, diceva: there is no software. Con questo intendeva dire che tutto, alla fine, deve tradursi a livello materiale dell’hardware, per esempio a livello dei microchip. Anche le interfacce delle piattaforme fanno riferimento a una concezione molto materiale del corpo, persino meccanica, ispirata dal comportamentalismo e il suo modello stimolo-risposta. Infine, le nuove tecnologie come le AI generative sono massicciamente materiali e hanno un impatto ambientale notevole. Quindi c’è una grande materialità nel digitale computazionale, ma è una materialità che ci sfida appunto a ripensare che cosa essa implichi e significhi. Non si tratta qui di rendere la materia vitale, ma di pensarla anche dal punto di vista della fisica post-classica, dalla teoria del caos alla fisica delle particelle. È una sfida fondamentale.
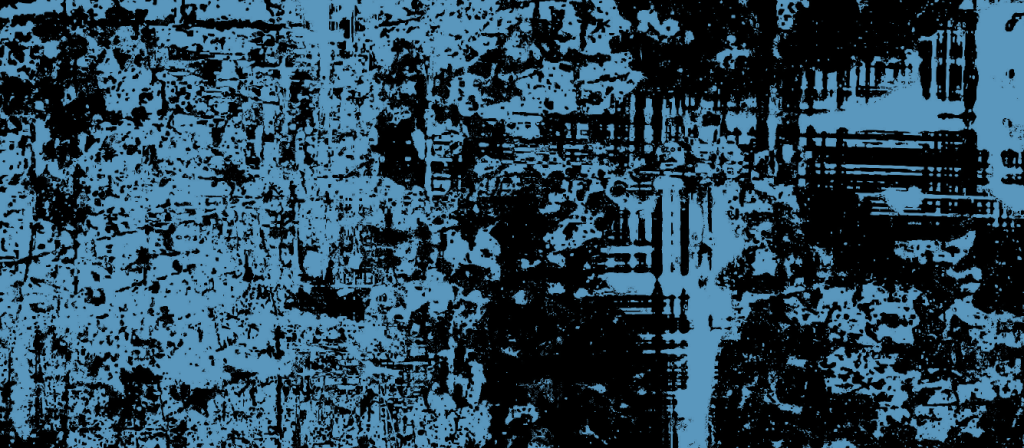
In questa fase post-digitale, vede qualche segnale premonitore di una trasformazione più radicale? Pensiamo a come le intelligenze artificiali generative stiano svuotando il web di traffico e come stiano alterando le nostre modalità di creazione di contenuti e immagini… Quale ulteriore evoluzione possiamo aspettarci?
È molto difficile capire come si evolveranno le cose. Nick Dyer-Witheford e Svitlana Matviyenko, in un loro recente volume, parlano di una tensione tra cyberguerra e rivoluzione. La militarizzazione digitale (per citare anche Adi Kuntsman e Rebecca Stein) non è da sottovalutare, anche nella sua dimensione di mobilitazione di massa degli utenti, ma neanche la pulsione alla trasformazione radicale dell’assetto di cose esistenti. Queste tensioni politiche sono l’ambiente costitutivo dei processi di sviluppo tecnologico in questo momento.